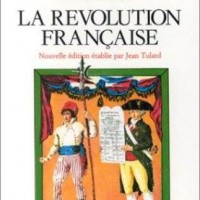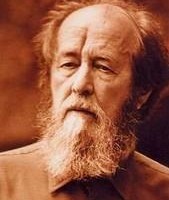Pierre Gaxotte, uno studioso contro il giacobinismo, di Marco Respinti.
Benemeritamente, la milanese Mondadori ha ristampato La rivoluzione francese. Dalla presa della Bastiglia all’avvento di Napoleone, di Pierre Gaxotte.
Nato il 19 novembre 1895 a Revigny-sur-Ornain, nel dipartimento della Meuse, nella Francia nordorientale, Pierre Gaxotte entra à l’École normale supérieure nel 1917. Nel 1920 vi consegue l’agrégation in Storia che, nel sistema scolastico francese, consente l’accesso alla docenza nel settore pubblico, mentre contemporaneamente ottiene una licenza in Scienze. Professore di liceo, stringe amicizia con Joseph Arthème Fayard (1866-1936), figlio del fondatore dell’omonima e prestigiosa casa editrice francese – Joseph-François Arthème Fayad (1836-1895) -, attraverso il quale viene presentato a Charles Maurras (1868-1952), il noto intellettuale della Destra monarchica e fondatore dell’Action française, di cui diventerà segretario.
Nel 1894, infatti, Fayard figlio, subentrato al padre nella direzione della maison, sposta gl’interessi della casa editrice dalla letteratura popolare ad autori decisamente conservatori come Maurice Barrès (1862-1923) e cattolici quali Paul Bourget (1852 -1935). Accanto a ciò, Fayard si lancia pure nell’affascinante mondo del feuilleton – un genere all’epoca popolarissimo, anzi pop -, monopolizzandone presto il mercato grazie al successo dei 32 romanzi della serie Fantômas, personaggio ideato nel 1911 da Marcel Allain (1885-1969) e da Pierre Souvestre (1874-1914), al centro pure di altri 11 romanzi composti poi dal solo Allain oramai “vedovo” di Souvestre. A Fayard si deve peraltro anche il lancio mondiale delle opere del prolifico scrittore belga Georges Simenon (1903-1989), padre del commissario Maigret.
Ebbene, alla ricerca costante di nuovi spazi editoriali e sempre al centro di coraggiose operazioni culturali, nel 1920 Fayard crea la collana “Grandes Études historiques” e ne affida la direzione a Gaxotte.
Fayard non è un editore neutro. Ha la netta percezione che la narrazione della storia – scritta sempre dai vincitori – e la produzione culturale – appannaggio di chi detiene il potere – necessiti, soprattutto del suo Paese, la Francia, emendamenti fondamentali rispetto ai cliché dominanti in cui trionfa la vulgata repubblicano-laicista e lo spirito massonico liberal-socialisteggiante. Per questo mette la propria casa editrice al servizio di una imponente opera revisionista che, coscientemente, concede ampi spazi all’ambiente umano, politico e culturale in quel contesto maggiormente dotato degli strumenti intellettuali adatti a rompere il monopolio del “pensiero unico”: la Destra, di cui proprio Gaxotte è un esponente noto.
DENTRO UN VESPAIO, CON CORAGGIO
Ora, la Destra in Francia è un vero dedalo. Ai tempi di Gaxotte e di Fayard è la sovrapposizione di anime diverse, persino di “correnti” contrastanti. In essa confluiscono, un po’ alla rinfusa, orientamenti e ispirazioni anche molto distanti tra loro, dai monarchici legittimisti ai cosiddetti orleanisti, dagli eredi del bonapartismo e quelli dello spirito vandeano, dai cattolici fedeli al Soglio di Pietro ai positivisti conservatori convinti che la religione – il cattolicesimo – svolga una essenziale funzione sociale di reazione e di supporto all’ideale monarchico teorizzando però che non è necessario crederci davvero (Maurras fu uno di loro, ma non così tutta l’Action française). Una Destra, insomma, in cui convivono, pur se a fatica, una “vera Destra” e una “Sinistra della destra”, quest’ultima essendo la somma – direbbe il più importante pensatore contro-rivoluzionario del secolo XX, il brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) – di molte “false destre”.
Il vizio di fondo degli ambienti più discutibili - e talora francamente impresentabili – di quella galassia è del resto il nazionalismo, sovente smaccato, che, nonostante una certa retorica ivi diffusa, è ideologia tra le ideologie. Per questo, infatti, alcuni di quegli ambienti finiranno per guardare con favore e dunque per affiancare i movimenti nazionalistici europei dell’epoca, sfociati poi in movimenti e in regimi fascisti (o fascistici). Del resto, nel brodo di cultura da cui nasce il “mussolinismo” – prima ancora del vero e proprio fascismo italiano – vi sono cospicui ingredienti francesi, dal sindacalismo rivoluzionario di Georges Sorel (1847-1922) al cosiddetto “boulangismo” (dal nome del generale Georges Boulanger, 1837-1891), vale a dire il movimento di opposizione che ,tra il 1886 e il 1889, accarezzò l’idea del golpe nazionalista.
Gaxotte però no. Aveva idee più chiare. Nuotò in quel mondo, militò tra i maurassiani, partecipò alle attività editoriali di Fayard che fiancheggiavano la “rivoluzione nazionale” auspicata dal leader dell’Action française, diresse i due settimanali politico-letterari lanciati dall’amico Arthème – Candide e Je suis partout, quest’ultimo divenuto, dopo la “gestione Gaxotte”, persino antisemita -, eppure non vi annegò mai. Gaxotte è stato infatti uno di quegli uomini di cultura e di scienza che non hanno mai disdegnato l’impegno politico, né nascosto le proprie idee controcorrente, ma che di certi ambienti hanno più che altro cercato di servirsi: per fare del bene e per indirizzare, anche a costo del fallimento.
Non scordiamo, del resto, che il privilegio offerto dal riflettere su determinati fatti a distanza di tempo è negato a chi i fatti li vive quando essi accadono. E che se questo certamente non assolve mai dalle responsabilità personali, altrettanto certamente non carica gli uomini liberi degli errori commessi da altri, anche magari molto prossimi. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) – per non citarne che uno – subì fortemente, all’inizio, il fascino del fascismo italiano; e suo cugino Arthur Kenneth Chesterton (1896-1973) fu invece smaccatamente fascista, antisemita e in collusione intellettuale con i nazisti. Per l’Action française di Maurras passarono comunque moltissimi intellettuali cattolici francesi certo non sospetti: il più noto di tutti fu il filosofo Jacques Maritain (1882-1973), che come molti altri poi se ne staccò, ma come scordare che in morte di Maurras tra i suoi laudatores figurò pure il Nobel T.S. Eliot (1888-1965)?
Read complete article in La Bussola Quotidiana
Aleksandr Solzenicyn e il cammino dell’”io” alla verità, di Giovanna Parravicini.
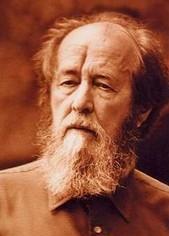 Vedendo tutta Mosca riscuotersi dal grigio torpore e accalcarsi intorno alle edicole per strappare una copia di «quella rivista dov’è scritta la verità» (nel novembre 1962 il prestigioso mensile Novyj mir pubblicava Una giornata di Ivan Denisovic, il primo racconto sui lager), giustamente Sergej Averincev osservava: «Questa ormai non è più solo storia della letteratura – è storia della Russia». La grande letteratura russa, del resto, non si è mai concepita solo come un fenomeno letterario, si è sempre sentita investita di una vocazione morale e pedagogica nel senso più elevato della parola, e così è sempre stata recepita dai suoi lettori, che potevano recitare senza esitazioni, come preghiere, accanto ai salmi le poesie del Dottor Zivago.
Vedendo tutta Mosca riscuotersi dal grigio torpore e accalcarsi intorno alle edicole per strappare una copia di «quella rivista dov’è scritta la verità» (nel novembre 1962 il prestigioso mensile Novyj mir pubblicava Una giornata di Ivan Denisovic, il primo racconto sui lager), giustamente Sergej Averincev osservava: «Questa ormai non è più solo storia della letteratura – è storia della Russia». La grande letteratura russa, del resto, non si è mai concepita solo come un fenomeno letterario, si è sempre sentita investita di una vocazione morale e pedagogica nel senso più elevato della parola, e così è sempre stata recepita dai suoi lettori, che potevano recitare senza esitazioni, come preghiere, accanto ai salmi le poesie del Dottor Zivago.
Il romanzo incompiuto di Solzenicyn Ama la rivoluzione!, finora inedito in Italia ma pubblicato ora dalla milanese Jaca Book, per la cura di Sergio Rapetti, a oltre cinquant’anni dalla sua composizione, ripropone questa grande lezione registrando, sullo sfondo del gigantesco dramma della seconda guerra mondiale, lo svolgersi di un altro dramma: il faticoso ma inarrestabile cammino dell’«io» umano verso la scoperta della verità, passando dagli slogan altisonanti e vacui dell’utopia («La vita era bellissima. In primo luogo perché era sottomessa alla volontà di Nerzin che poteva disporne a suo piacimento [...]. Era cresciuto nella convinzione che ogni uomo debba forgiare da sé il proprio destino»), al terreno aspro e accidentato, ma solido, della realtà («[…] quello sguardo di migliaia, inflessibile, cupamente testardo ma che senz’altro racchiudeva un segreto, un segreto senza il quale sarebbe stato impossibile vivere»). È il cammino percorso da un intero popolo, di cui Solženicyn ha sempre avvertito la responsabilità di custodire la memoria e la coscienza, e insieme il suo stesso cammino personale, tracciato attraverso la figura del protagonista, Gleb Nerzin (lo stesso nome prenderà il protagonista nel successivo, maturo romanzo Il primo cerchio).
Ama la rivoluzione!, presentato alla Biblioteca Ambrosiana l’8 marzo scorso alla presenza di Ignat Solženicyn, uno dei figli dello scrittore, narra la vicenda di un giovane intellettuale sorpreso dallo scoppio della guerra nelle aule universitarie di Mosca, impaziente di combattere in prima linea per aggiudicare alla patria la vittoria finale e portare la rivoluzione in tutto il mondo, ma costretto – in quanto riformato alla visita medica – a una poco esaltante marcia verso le retrovie in un reparto di salmeria («il contingente degli invalidi»).
È un’opera profondamente autobiografica, scritta da Solženicyn nel 1948 mentre era internato in un campo di lavoro per scienziati, la saraska di Marfino, fortunosamente messa per iscritto (a differenza di altre opere dello stesso periodo, in particolare il poema La stradina, 8mila versi serbati per anni dall’autore nella memoria), e salvata da una coraggiosa funzionaria del lager che gliel’avrebbe restituita sei anni dopo. Un’opera in cui l’autore fissa il mutamento che sta avvenendo in lui, intellettuale comunista e brillante ufficiale arrestato durante la guerra, costretto dalle circostanze a rivedere tutte le proprie convinzioni.
L’ingloriosa marcia di Gleb, che cerca disperatamente, lungo tutta la narrazione, di mutarne la rotta per inseguire i suoi ideali, è in realtà il percorso della vita, che si incarica, per Nerzin come per Solzenicyn, di liberare l’intellettuale entusiasta, confidente nel «giovane paese dalla rossa bandiera», dalle sue utopistiche convinzioni. È un processo liberatorio che avviene secondo un duplice registro: il tribunale della storia e il tribunale della coscienza qui si uniscono per ricondurre la persona a se stessa. A questo conduce lo scontro di Nerzin con la burocrazia, la miopia e gli interessi individuali che soppiantano nel sistema i luminosi ideali del socialismo e, più in generale, ogni idea di giustizia e di bene comune («viveva e soffriva il tracollo sempre più evidente dell’Armata Rossa come la malattia mortale di un congiunto… A quale scopo vivere se ciò che di più luminoso era apparso nella storia dell’umanità veniva soffocato?»); a questo conduce il suo scontro con l’atrocità delle repressioni, della vita ai lavori forzati e in deportazione attraverso i racconti dei nuovi vicini di casa, i Diomidov, che squarciano un velo su una realtà apparentemente remota ma in realtà così prossima da sfiorare il protagonista e la moglie.
Read complete article in La Bussola Quotidiana
William Buckley, il demiurgo dei conservatori; by Marco Respinti
«Kennedy si lamenta continuamente che noi stiamo tentando di diffondere il messaggio comunista in tutta l’America latina. Che si lamenti pure. Diffondere la rivoluzione è affar nostro». Così Fidel Castro arringa i compagni nel thriller di William Frank Buckley jr. Caccia alla mangusta (trad. it., Sonzogno, Milano 1988) dove la CIA cerca di far fuori il líder maximo alla vigilia dell’attentato che invece ucciderà JFK.
Caccia alla mangusta è un’opera di fantasia, certo; eppure Buckley qualcosina delle mosse della CIA la sapeva per davvero. Per molti versi Blackford Oakes, il protagonista dei suoi gialli (scontato il riferimento allo 007 di Ian Fleming, anche se qui l’agente è americano), interpreta Buckley stesso: sciccherie, Ivy League e qualche scrupolo morale quando è l’ora di premere il grilletto. Ma su quel melange di fiction e di verità storiche, di cui si compongono giocoforza i polizieschi buckleyani, la precedenza logica e cronologica l’ha proprio il rapporto di amorosi sensi con l’Agenzia, quella vera. Senza di essa, Buckley non sarebbe infatti mai stato Buckley; negli Stati Uniti non ci sarebbe mai stato il movimento conservatore; alla Casa Bianca si sarebbero seduti altri presidenti; insomma, il mondo sarebbe stato diverso. Buckley è allora la prova provata del complottone dei servizi segreti? Qualcuno lo ha pensato e pure scritto, ma ci si è guadagnato solo il Nobel del fantasy (che per l’appunto non esiste).
Buckley è infatti sempre stato troppo originale, libero, istrionicamente indomabile e talora persino stizzoso per agire da semplice figurante o far da fantoccio. E poi ha sempre avuto più classe. Mettiamola così: ebbe una idea geniale; la trasformò in un progetto serio quando a qualche cocktail incontrò le persone giuste che avevano la forza pratica di fargliela realizzare; se ne servì con una eleganza che ha fatto invidia a molti; e nel mezzo ci si è pure divertito. La CIA? Sia lode, se uno come Buckley ha saputo aggiogarla ad maiora.
Di Buckley il 27 febbraio sono ricorsi quattro anni da quando fu trovato, 82enne, stroncato da un colpo al cuore sul pavimento della sua casa di Stamford, in Connecticut, dove da qualche anno si era oramai ritirato. Non certo a vita privata, ma a riflettere su quella sua esistenza lunga, e ricca, e perché no pure felice, apparecchiandosi alla morte. Paura no, interrogativi sì. Sapeva a menadito, perché tutti i conservatori old-style lo sapevano a menadito, quella frase che Platone mette in bocca a Socrate, «Una vita non esaminata non è degna di essere vissuta», e lui di cose da esaminare ne aveva tante.
Nel 1997 aveva pubblicato Nearer, My God to Thee: An Autobiography of Faith (Doubleday, New York) chiedendosi profondamente di Dio, di quel Dio cristiano e cattolico che amava in modo profondo e maschio, anche guascone ma sempre devoto. Chiedersi di Dio, della morte e pure del dopo è infatti lecitissimo se si è credenti della stoffa di Buckley, cioè cattolici “da rito antico”, “Catechismo di san Pio X” e interesse per la mistica italiana Maria Valtorta (1897-1961). Era del resto venuto su così, Buckley, rampollo di quelle gang altolocate e un po’ puzzosottoilnasiste che a New York un tempo c’erano e che sono state anche fucina di cattolici tutti d’un pezzo, finiti poi a ingrossare le fila del mondo conservatore. Lì Buckley nacque nel 1925.
Ricordo distintamente quando, qualche anno prima dell’uscita in libreria di Nearer, My God to Thee, Russell Kirk (1918-1994), il decano dei conservatori, ricevette da Buckley – come la ricevettero alcuni altri spiriti magni di quel mondo – una richiesta di proferire qualche pensiero forte su Dio da rimuginare e macerare in quel suo libro di molto dopo, faticoso, accidentato, che egli andava lentamente costruendo. La fede granitica di Buckley riposava certamente sulla dottrina della Chiesa dei cattolici e però questa egli un dì l’apostrofò «madre sì, maestra no», facendo pure un po’ di confusione fra Papa, clero e teologi, al tempo del post-Concilio aggressivamente sbalestrato. A tratti fu interlocutoria anche la sua fede, magari persino dubbiosa, ma dov’è lo scandalo? La vertigine sublime del fascino di Dio che tutto abbraccia si palpa sempre in ogni cosa che Buckley ha scritto, e detto, e fatto, persino negli svarioni e negli errori, che sono pure stati tanti e grandi, proprio come tanti e grandi sono stati suoi nemici e i suoi critici che spesso avevano più ragione di lui ma altrettanto frequentemente carità pochina.
Read complete article in La Bussola Quotidiana
Ungheria: orgoglio e identità, by Andrea Camaiora.
«C’è qualcuno che avrebbe preferito che non avessimo menzionato re Santo Stefano nel preambolo alla nostra nuova Costituzione. Ebbene, se non lo avessimo fatto avremmo negato le nostre radici, la nostra storia, in una parola la verità». È apparso convincente, determinato, carismatico il parlamentare europeo PPE József Szájer, in visita a Roma lunedì per un incontro con la stampa, al mattino presso la sede dell’ambasciata ungherese, e in serata con gli studenti della prestigigiosa John Cabot University.
Szájer, praticamente sconosciuto in Italia, non è un politico qualunque nel suo Paese. Ha presieduto la Commissione per la Redazione della Legge Fondamentale Ungherese ed è a lui che si deve il celebre e contestato preambolo che recita: «Noi, appartenenti alla nazione ungherese, all’inizio del nuovo millennio, provando senso di responsabilità per ogni nostro connazionale, proclamiamo: Siamo orgogliosi che il nostro re Santo Stefano [nella foto] abbia costruito lo Stato ungherese su un terreno solido e abbia reso il nostro paese una parte dell’Europa cristiana mille anni fa. Siamo orgogliosi dei nostri antenati che hanno combattuto per la sopravvivenza, la libertà e l’indipendenza del nostro paese. Siamo orgogliosi delle eccezionali conquiste intellettuali del popolo ungherese. Siamo orgogliosi che il nostro popolo nel corso dei secoli abbia difeso l’Europa in una serie di lotte e arricchito i valori europei comuni con il suo talento e diligenza. Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nel preservare la nazione. Apprezziamo le varie tradizioni religiose del nostro paese. Ci impegniamo per preservare l’unità intellettuale e spirituale della nostra nazione lacerata nelle tempeste del secolo scorso. Le nazionalità che vivono con noi fanno parte della comunità ungherese politica e sono parti costitutive dello Stato».
L’europarlamentare di Fidesz (il partito di Viktor Orban) ha spiegato ai pochi giornalisti presenti in sala – tra i quali si notavano le clamorose assenze di la Repubblica, Corriere della Sera e Sky, testate tra le più ferocemente critiche nei confronti dell’attuale situazione politica ungherese – che gli ungheresi hanno assistito alle durissime critiche ricevute per la libera e sovrana scelta di dotarsi di una nuova Carta con una certa perplessità e ha spiegato il perché: nel 1222 re Andrea II d’Ungheria emanò la cosiddetta Bolla d’oro, ovvero un atto molto simile alla Magna Charta emanata in Inghilterra solo quattro anni prima, che impegnava il sovrano a rispettare certi limiti nella sua azione e che rappresenta pertanto la prima “Costituzione” dell’Europa continentale.
József Szájer ha avuto modo di ribadire che la scelta di dotarsi di una nuova Costituzione era molto sentita dagli ungheresi anche perché le istituzioni democratiche sviluppatesi man mano dal 1990 in poi, poggiavano sempre e comunque sull’ormai datato e discusso testo della Costituzione sovietica del 1949 «copiata sic et simpliciter dalla costituzione sovietica del 1936».
Szájer ha pure risposto alla giornalista di Radio Radicale Ada Pagliarulo che chiedeva le motivazioni che avevano portato a non iscrivere il rifiuto della pena di morte nella Carta del 2011 che gli ungheresi da vent’anni hanno definitivamente abolito la pena di morte aderendo anche a trattati internazionali che ne impediscono nuovamente l’adozione: «la nostra Costituzione – ha però ricordato l’europarlamentare magiaro – sancisce l’inviolabilità della persona, il primato della vita e altri principi di grande importanza».
Nel corso dell’incontro nella sede diplomatica magiara è emerso, sempre con riferimento alla tanto contestata nuova Carta, che la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha espressamente dichiarato di apprezzare «il fatto che questa nuova Costituzione stabilisce un ordine costituzionale basato sulla democrazia, lo stato di diritto e la protezione di diritti fondamentali quali principi basilari» (L’Opinione, 20 giugno 2011).
Read the complete article in La Bussola Quotidiana
Se la cristianofobia è un’occasione, by Marco Respinti.
«Nel mondo islamico, i cristiani vengono massacrati per la loro fede religiosa. Siamo davanti a un genocidio dilagante che dovrebbe suscitare allarme a livello globale». Lo sappiamo. Ma che la denuncia campeggi dalla copertina di Newsweek è una vera notizia.
Il settimanale statunitense ha dedicato al tema un ampio servizio che porta la firma famosa e impegnativa di Ayaan Hirsi Magan Ali. Nata a Mogadiscio, figlia di un signore della guerra somalo, “rinata” nei Paesi Bassi, Ayaan diventa famosa quando, il 2 novembre 2004, il regista neerlandese Theo van Gogh, per il quale aveva scritto la sceneggiatura del cortometraggio Submission, viene ucciso da Mohammed Bouyeri, killer musulmano di origini marocchine. Da allora la Ali vive sotto scorta, si è trasferita a Washington dove lavora per il neoconservatore American Enterprise Institute for Public Policy Research e della sua irriducibile avversione all’islam non fa alcun mistero. Meno digeribile è invece le sua critica piuttosto laicista della religione.
Ayaan non rivela certo novità travolgenti quando ricorda le stragi efferate di Boko Haram in Nigeria, le mattanze che lordano di sangue cristiano il Sudan, l’ordalia continua di un Paese, l’Egitto, le cui “giovani promesse” hanno pensato bene di inaugurare la “corsa alla democrazia” massacrando 23 copti il 1° gennaio 2011 nella Chiesa dei Santi di Alessandria (famosissima la foto del Cristo macchiato di sangue che anche Newsweek sceglie per la copertina), le violenze anticristiane in Iraq, la situazione intollerabile del Pakistan e l’Arabia Saudita custode dei “luoghi santi” dell’islam che vieta con rigore più che zelante la costruzione di qualsiasi edificio di culto cristiano. Ma il punto vero è che questo compitino diligente e utile compaia con grande enfasi sulla copertina di un settimanale non certo di apologetica cristiana scritto non certo da una missionaria (chi non masticasse l’inglese può contare sulla traduzione, parziale, che il 13 febbraio ne ha offerto il Corriere delle Sera nella pagina degli Esteri, la 17esima, senza nemmeno un richiamo in prima).
Ciò – ipotizziamo – avviene per tre motivi. Il primo è che l’evidenza dei massacri anticristiani è tanto grande e cogente che nessuno, meno ancora un entourage di professionisti di primo piano come quello che produce Newsweek, può permettersi di continuare a bucare la notizia.
Il secondo è il fallimento palese delle cosiddette “primavere arabe”, indossate acriticamente da tutti ma ora rovesciatesi (ed era facilissimo prevederlo da subito) nell’esatto contrario di quanto auspicati dal “buonismo”. Che i copti rimpiangano i giorni di Hosni Mubarak – che pure li angheriava – per non rassegnarsi alla “piazza salafita” e che ai “ribelli” gli assiri preferiscano Bashar Assad – che, ricambiati, non amano – è totalmente paradossale quanto altamente significativo.
Terzo, ultimo e forse a lungo termine più fecondo motivo è che un certo mondo, quello che Newsweek se non altro fotografa bene, quello per intendersi che pensa ai propri tornaconti, alle “magnifiche sorti e progressive”, alla Chiesa se può darle addosso, insomma un certo mondo laico-laicista e radical-chic, si rende conto che solo i cristiani sono seme di civiltà. Che una sola è la cultura che genera il vero umanesimo dei diritti e delle libertà. Che se in Medioriente, Africa e Asia trionfasse il modello islamico, il mondo come lo abbiamo conosciuto finirebbe, prospettando poco di buono per quello che lo sostituirà. Insomma, che se là dove sono minoranza vessata e perseguitata perdiamo i cristiani come interlocutori del nostro mondo diviso tra postcristianesimo e nuova evangelizzazione, cioè come pilastri e architravi di isole di società autenticamente «a misura d’uomo e secondo il piano di Dio» (beato Giovanni Paolo II) dove invece di Dio vige un’idea errata e quindi l’uomo muore, tutto è perduto.
Ai tempi in cui il Libano era lacerato tra quattro eserciti invasori e i cristiani ne pagavano il prezzo, l’allora Segretario di Stato americano cinico e liberal Henry Kissinger pensò che la soluzione ottimale fosse che i maroniti, segno di contraddizione ma unica condizione di pace vera, lasciassero il Paese, ridislocandosi per esempio in quel Canada dove di spazio ne hanno da vendere. Ecco, la mano che Newsweek decide di tendere oggi alla lotta contro la “cristianofobia” suggella il tramonto definitivo di quella prospettiva sciagurata, un’azione fattualmente meritoria quali che ne siano le ragioni.
Da che conseguono due cose fondamentali: la prima è che, giunta pure la benedizione liberal, ora non ci sono più scuse per tollerare oltre la strage; la seconda è che la difesa pur strumentale dei cristiani da parte dei liberal è comunque un’occasione d’oro per cominciare a rievangelizzare anche la parte peggiore dell’Occidente. Finché infatti i popoli e le persone continueranno a saltare il mare per venire da noi, mentre invece nessuno fa l’inverso – se ne rende conto pure Newsweek -, avremo su tutti un incommensurabile vantaggio apologetico.
Complete article and more stories here